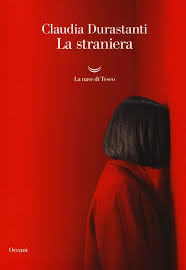Destinatari: Adulti Livello: B2/C1 Cristina Di Bari
La straniera
La letteratura nella didattica dell’italiano agli stranieri
Unità 5 – La migrazione in Italia e dall’Italia oggi
Attività 1: L’avvicinamento al testo
Leggi le due citazioni e commentale rispondendo a queste domande con una registrazione vocale.
«Quando sono emigrata a 27 anni a Londra ero convinta di avere tutte le carte in regola per essere la migrante di successo, quella che si sarebbe radicata, perché conoscevo la lingua. Invece mi sono resa conto con una sorta di malinconia, a tratti astiosa, che non mi ero adattata affatto e che paradossalmente mia nonna a New York si era adattata con molta più facilità pur non parlando l’inglese». (Claudia Durastanti, La straniera, pag 155)
«Possiamo fallire una storia d’amore, il rapporto con una madre. Ma quando una città ci respinge, quando non riusciamo ad entrare nei suoi meccanismi più profondi e siamo sempre dall’altra parte del vetro, subentra una sensazione frustrata di merito, che può farsi malattia. Straniero è una parola bellissima, se nessuno ti costringe ad esserlo; il resto del tempo, è solo sinonimo di una mutilazione, e un colpo di pistola che ci siamo sparati da soli». (Claudia Durastanti, La straniera, pag 156)
- Qual è la tematica principale di entrambi i testi?
- A che cosa paragona il sentimento di “essere una straniera”?
- Sei d’accordo con questi paragoni? Ti è mai capitato di sentirti “straniero/a”?
- Pensi che basti conoscere la lingua per ambientarsi in un luogo?
- Hai mai letto romanzi o racconti su questo argomento?
Attività 2: La comprensione del testo
CLAUDIA DURASTANTI, LA STRANIERA, Milano, La Nave di Teseo, 2019, pp. 95-96
Leggi il brano e svolgi gli esercizi.
“La straniera” è un romanzo autobiografico in cui la scrittrice, Claudia Durastanti (Brooklyn 1984), descrive la sua esperienza familiare tra New York, la Basilicata, Roma e Londra, concentrandosi sull’analisi della propria identità linguistica e culturale anche in rapporto alla disabilità dei genitori.
In questo brano l’autrice racconta del suo arrivo in Italia e del suo apprendimento della lingua italiana attraverso i romanzi.
Quando il sole tramonta in Basilicata il cielo diventa un polmone che espettora sangue, la sua luce fa più tossire che commuovere. Io venivo dall’asfalto, e in quel paese c’erano solo pietre.
Il primo giorno di scuola ero arrivata con le mie Reebok dotate di lucette, lo smalto fucsia e i capelli cotonati, senza grembiule. Mi ero appena seduta quando la maestra aveva detto che il giorno dopo avrei dovuto vestirmi come tutte le altre. Mi aveva messo al centro della classe per farmi socializzare con tutti, ma da quel momento sono diventata un’isola, mortificata dalla mia autosufficienza e sempre affacciata sull’affetto degli altri.
Ho imparato a leggere e scrivere in italiano, ma la mia lingua conteneva sempre un margine di errore che faceva ridere gli insegnanti. Dicevo “stiro da ferro” invece di “ferro da stiro”, “bega” invece di “busta” e quando dovevamo scrivere i nostri piatti preferiti, disegnavo degli hot dog ma li chiamavo “frankfurt”, dalla tipologia di quelli che comprava mia madre a Brooklyn, e dunque era sbagliato pure quello. […]
Topolino serviva a insegnarmi l’italiano e a darmi una proprietà lessicale, non avrei mai imparato a usare la parola “esilarante” o “scavezzacollo” altrimenti, mentre i romanzi gotici mi lasciavano in eredità le parole “crepacuore” e “consunzione”. E poi c’erano quegli altri libri, quelli della strada, che erano i miei preferiti.
È in quegli anni di soffitta che Fernanda Pivano è diventata la mia migliore amica. Mia madre aveva le sue traduzioni di Kerouac e Fitzgerald traduzioni che avrei scoperto essere piene di errori e di incuria solo all’università, quando tutti la prendevano in giro, ma non mi sarebbe importato: io di errori nella traduzione ne facevo sempre e continuo a farli, perché nessun significato assume una forma stabile in me, e tutto quello che penso, e quello che poi dico, soffre nella trasmigrazione tra paesi diversi, sanguinando proprio come gli astronauti che hanno trascorso troppo tempo nello spazio e quando tornano a casa hanno epistassi continue sotto il sole.
Comprensione globale
Comprensione analitica
Per approfondire: la scrittrice racconta il suo romanzo.
La straniera non è senza patria, ma è chi ne ha tante. È un privilegio ma anche una responsabilità.
Attività 3: La produzione di un testo
Prendendo spunto dal brano letto, scegli almeno due autori e libri che sono stati importanti per la tua crescita come lettore o lettrice e raccontali in un audio. Se lo hai fatto, puoi scegliere i libri che hai letto in italiano spiegando la tua esperienza di lettura (difficoltà incontrate, metodo seguito, punti di forza…).
Di questi libri indica autore, titolo, anno di pubblicazione, genere letterario e riassumi brevemente la trama, le tematiche principali e perché sono importanti per te.
Puoi inserire queste informazioni anche nella piattaforma Padlet (link: https://padlet.com/cdibari/i-miei-libri-e-autori-preferiti-2zkwp1tckc3e3st5) come audio o testo scritto e, se vuoi, aggiungere delle immagini (copertina, autore, ambientazione…).